

Il tema, oggetto della discussione in argomento, rientra nella sfera cronologica del novecento, periodo storico al quale il Circolo Culturale L'Agorà rivolge attenzione da tempo.
Ciò che ha scatenato la guerra del Vietnam ha radici antiche, infatti nel corso del suo intervento Gianni Aiello evidenzia che [...nell'agosto del 1945 la rivoluzione condotta dal Viet Minh conquista il potere successivamente ad Hanoi, a Hué - dove l'imperatore Bao-Dai abdica - e a Saigon. Il 2 settembre Ho Chi-minh proclama ad Hanoi l'indipendenza del Vietnam e l'avvento della Repubblica democratica. Il giovane Stato riesce a superare difficoltà di ogni genere: economiche, finanziare, politiche. Malgrado la convenzione del 6 marzo 1946 che riconosce il Vietnam come «Stato libero in seno all'Unione Francese», i Francesi - che hanno rioccupato il Sud, la Cambogia e il Laos e credono di poter riconquistare facilmente il Nord - adottano una politica «del fatto compito», incoraggiando il separatismo sudista. Il 19 dicembre 1946, il bombardamento di Haipong porta a una generalizzazione delle ostilità. Mentre la lotta dell'Indonesia ha beneficiato di un vasto movimento di opinione internazionale a proprio favore, e l'intervento delle grandi potenze (che vi possiedono grandi interessi) ha posto fine abbastanza rapidamente al conflitto, il Vietnam per molto tempo ha dovuto contare solo sulle proprie forze, e la guerra con la Francia si è prolungata per otto anni. Questa differenza si spiega con la natura «comunista» della direzione rivoluzionaria (che ha «infastidito» alcuni governi), la rete delle alleanze francesi (Parigi era un pilastro della difesa atlantica e nello stesso tempo era legata a Mosca da un trattato di amicizia), l'assenza di investimenti stranieri (al contrario degli Olandesi, il capitalismo francese era riuscito a fare dell'Indocina una «riserva di caccia». Imponendo all'avversario la propria strategia il Vietnam otterrà, infine la vittoria militare. Ma essa è stata, prima di tutto, una vittoria politica. ...] . (1)
Nel corso del suo intervento Gianni Aiello anche i principi della strategia di Truong Chinh posti al bivio tra la guerra anti-imperialista e quella rivoluzionaria, aspetti questi indirizzati verso un mondo migliore.
Tali direttive riguardavano anche l'organizzazione dell'unità nazionale del Paese, l'isolamento dei colonialisti, la ripresa economica, sociale, culturale.
Altro aspetto fondamentale di quel manifesto era rivolto alla struttura delle fasi belliche:
□ guerra difensiva;
□ guerra di resistenza;
□ controffensiva generale.
A conclusione del suo intervento, Gianni Aiello ha dato lettura di alcuni episodi che interessarono dal punto di vista emotivo anche la città di Reggio Calabria, come alcune manifestazioni antimilitariste e la presenza di un giovane sergente, originario della provincia di Reggio Calabria tra le fila dei marines statunitensi , dati questi consultabili nelle pagine della cronologia del Circolo Culturale L'Agorà.
La parola è passata poi ad Alessandro Crupi che ha trattato il tema inerente a "La politica diplomatica dell'Italia durante la guerra del Vietnam".
Il conflitto combattuto in Vietnam dal 1962, anno dei primi bombardamenti statunitensi nel Vietnam del Sud per destabilizzare il governo Diem, al 1975, momento della presa di Saigon da parte dei nordvietnamiti, presenta diversi elementi di originalità rispetto alle guerre precedenti, soprattutto a livello comunicativo e sociale oltre che storico-politiche.
I fatti che accadono in Vietnam, infatti, divengono oggetto di un importante dibattito giornalistico e politico, fatto unico nella storia del Novecento fino all’inizio degli anni Sessanta.
Ciò favorisce il pieno manifestarsi di un’opposizione di massa sempre crescente attraverso l’attivismo di un vasto movimento che costituirà il preludio al dispiegarsi del movimento giovanile sul finire del decennio.
Inoltre la guerra del Vietnam rappresenta la prima “guerra televisiva” della storia, i cui sviluppi (ed anche orrori) divengono oggetto di “consumo” da parte di un mondo mediatico in costante ascesa sotto tale profilo.
Per questa serie di ragioni, uno dei motivi principali che mi ha spinto a concentrare lo studio su questo evento storico nasce dalla consapevolezza dell’influenza generata dal conflitto vietnamita nella società, non solo del periodo in cui esso si svolge, ma anche in quella che caratterizza le generazioni successive avendo posto le basi nella costruzione e rafforzamento di alcune prerogative essenziali presenti oggi nella realtà moderna che concernono anche il modo di fare comunicazione oggi.
Premesso questo sarebbe riduttivo inquadrare le fasi del conflitto in una prospettiva basata solamente sulla contrapposizione tra Usa e Vietnam del Nord.
Se da una parte, infatti, è innegabile che sul territorio indocinese, fronte della guerra, i principali protagonisti siano stati gli eserciti delle due repubbliche vietnamite e le milizie americane, ciò non significa, tuttavia, che questo accadimento storico possa essere osservato quasi esclusivamente sul piano delle armi e delle forze in campo trascurando il contesto internazionale in cui esso si è via via sviluppato e, conseguentemente, gli attori politici di questo scacchiere, intervenuti a vari livelli nel fatto.
Nel momento in cui gli Stati Uniti d’America prendono il posto dei francesi nel controllo dell’area si viene a formare un coinvolgimento generale manifestato sia dall’opinione pubblica che da numerosi governi del mondo e che tocca il suo massimo livello durante l’escalation nelle operazioni militari tra il 1963 e il 1968.
La situazione politica e militare si deteriora determinando il massiccio intervento statunitense che si esplica in un quadro storico particolarmente delicato e monopolizzato da un tema prevalente: l’evoluzione dei rapporti tra i due colossi da cui dipendono le sorti politiche e storiche del mondo in quel momento: Usa e Urss.
«Ci troviamo, infatti, - prosegue Alessandro Crupi - nel periodo immediatamente successivo al superamento della crisi di Cuba, che sicuramente lascia prevedere uno speranzoso futuro di distensione ma che nello stesso tempo non fa dormire sonni troppo tranquilli in quanto esso si fonda su equilibri ancora troppo fragili, dove ogni minimo cambiamento degli assetti politici regionali a livello internazionale può essere causa di ulteriori frizioni tra le due superpotenze con elevati rischi degenerativi.»
Il conflitto in Vietnam poteva rappresentare, quindi, un pericolo considerando che Cina e Urss avevano interesse a controbilanciare politicamente il territorio vietnamita, tramite il sostegno ad Hanoi, da un’eccessiva influenza statunitense, che nel conflitto tra Nord e Sud sosteneva invece Saigon.
Tutto ciò, unito al timore di un peggioramento della situazione mondiale, determina l’interessamento alle vicende del Vietnam di diversi protagonisti sulla scena internazionale fra cui anche l’Italia.
Il coinvolgimento del nostro Paese nella guerra che si combatte sulla penisola indocinese si attua a livello di opinione pubblica e di scelte politico-diplomatiche.
Tutti elementi, tra loro intimamente legati.
Le fronde pacifiste, che fanno sentire in maniera viva la loro presenza in quel periodo, si vengono anche a rapportare con un diffuso sentimento antiamericano, emerso soprattutto nel dopoguerra dopo la scelta “occidentale” decretata dall’Italia con la ratifica del Patto Atlantico, e spesso utilizzato per scatenare la “crociata” nei confronti dell’imperialismo statunitense.
Molto importante si rivela, a questo proposito, la panoramica dei sentimenti più significativi acquisiti dall’opinione pubblica, dai movimenti pacifisti cattolici e di sinistra e dalla politica italiana nel periodo antecedente all’escalation del conflitto vietnamita per comprendere più chiaramente lo stesso fatto storico e le varie posizioni degli attori-protagonisti in campo politico e diplomatico.
Fino ad oggi si è sempre detto troppo poco sul ruolo dell’Italia nella guerra in Vietnam e, come si accennava in precedenza, si tende a concentrare i confini dello stesso conflitto in un alveo internazionale eccessivamente ristretto.
L’Italia, invece, ha mostrato proprio in questo frangente della storia del mondo un notevole attivismo attraverso una serie di azioni ed interventi sullo scenario interno ed internazionale che hanno condizionato le vicende del Vietnam contribuendo al suo sviluppo e alla sua conclusione.
In questa analisi un occhio di riguardo particolare va gettato sul ruolo svolto da politica, diplomazia, opinione pubblica e, anche, la Santa Sede nell’adoperarsi al raggiungimento di un compromesso pacifico in Vietnam per porre fine alle brutture del conflitto.
Negli anni del conflitto i condizionamenti ideologici impregnano la società italiana e caratterizzano le iniziative di vari parlamentari ed esponenti di partito sulla scena politica nazionale.
Il dibattito, in quegli anni, è largamente dominato dalle posizioni dei partiti principali come la Dc, il Psi e il Pci.
Nell’orientamento internazionale della classe dirigente italiana prevale una certa vicinanza alle azioni compiute dagli Usa nel Sud-est asiatico, pur se con qualche riserva ed oscillanza che risente dell’impopolarità del conflitto nell’opinione pubblica italiana e del rapporto con le forze di sinistra, da sempre contrarie alle operazioni militari.
Questa linea di pensiero viene confermata a più riprese dal Presidente del Consiglio Aldo Moro che, spesso, giustifica l’intervento armato americano, soprattutto nel periodo dell’escalation.
Nel Partito Comunista la condanna dell’imperialismo americano, invece, rappresenta l’input da cui si dipana la mancata condivisione dell’intraprendenza statunitense in una visione fortemente ideologizzata.
Il leader dei socialisti Pietro Nenni, invece, pur non facendo mistero delle proprie rimostranze nei confronti de conflitto, deve tenere conto di non far saltare gli equilibri esistenti all’interno della coalizione di centro-sinistra e di non creare divisioni all’interno del partito.
Sul piano diplomatico, è stato Giorgio La Pira, ex sindaco di Firenze e valido esponente della politica italiana, ad inaugurare la stagione delle iniziative italiane incentrate sul conflitto vietnamita attraverso il suo viaggio nel Vietnam del Nord nel 1965.
La serie di colloqui intavolati con i governanti di Hanoi, pur se infruttuosi sul piano del risultato finale, svolge un ruolo fondamentale nella diplomazia italiana rivolta al Vietnam, fornendo la base negoziale e la spinta decisiva alle successive iniziative di mediazione tra Italia e Stati Uniti portate avanti dall’ambasciatore D’Orlandi tramite le cosiddette Missioni “Marigold” e “Killy” tra il 1966 e il 1968.
La Missione “La Pira”, inoltre, genera vaste ripercussioni sia in campo politico che sul fronte dell’opinione pubblica e, in questo settore, c’è spazio anche per la contestazione giovanile del Sessantotto in cui, tra l’altro, le drammatiche notizie provenienti dal Sud-Est asiatico assumono una posizione centrale nel corso della protesta.
Le Missioni “Marigold” e “Killy” riflettono l’indirizzo politico del governo di centro-sinistra in politica estera esposto da Aldo Moro all’inizio del ’66.
Il canale denominato “Marigold” vede come attore principale l’ambasciatore italiano a Saigon Giovanni D’Orlandi.
Si tratta della pianificazione di una serie di trattative complesse tra Usa e Vietnam del Nord in cui vi entra anche il delegato polacco della Commissione Lewandowski ma il negoziato, nonostante le buone premesse di base, non avrà mai luogo.
Anche la successiva iniziativa diplomatica nota come Missione “Killy” non avrà esito positivo ma è opinione generale che essa contribuisca a favorire la convocazione della conferenza di Parigi dove si aprono effettivamente reali negoziati tra le parti.
Il fervente lavoro svolto dalla nostra diplomazia ha avuto un merito particolare e molto importante: quello di aver preparato il campo alle trattative intavolate negli anni successivi fino alla deposizione definitiva delle armi.
C’è da far notare, inoltre, che in quegli anni l’atteggiamento dell’Italia nei confronti degli Stati Uniti all’interno del Patto Atlantico non è aprioristicamente favorevole a qualunque scelta operata dal principale alleato occidentale.
Proprio verso la metà degli anni Sessanta, infatti, in coincidenza con l’escalation del conflitto, il governo italiano irrigidisce le proprie posizioni sulla guerra instaurando una sorta di confronto con gli Usa che parte anche da valutazioni critiche.
Durante il lavoro di ricerca che mi ha portato a queste conclusioni ci si è potuti avvalere del contributo dei pochi lavori concernenti il ruolo dell’Italia durante la crisi del Vietnam.
Le fonti documentarie hanno consentito di arricchire di contenuti le memorie dell’iniziativa diplomatica italiana e le istanze pacifiste espresse da cattolici e forze di sinistra nell’ambito del dibattito politico. Fondamentale si è rivelato, a tal proposito, il contributo dei documenti diplomatici americani della raccolta “Foreign relations of the United States” e le varie testimonianze sul tema del pacifismo cattolico e di sinistra.
A livello documentario, inoltre, è stato molto prezioso l’esame dei verbali di alcune sedute di Camera e Senato, cruciali per ricostruire con dovizia di particolari la posizione politica italiana sulla questione vietnamita.
La connessione organica fra tutti gli elementi della partecipazione del nostro Paese alle vicende del Vietnam è stata resa possibile anche dalla rassegna dei quotidiani che ha offerto un contatto diretto dei differenti punti di vista e delle reazioni alla guerra manifestati dal mondo politico e sociale del nostro Paese, oltre che di integrazione e completamento della documentazione storico-diplomatica nazionale, ancora oggi disponibile.
Gianluca Tripodi ha trattato il tema relativo a "La politica statunitense in Vietnam: evoluzione e sviluppi attraverso la condotta della guerra" ed i cui contenuti non sono stati una pura disamina cronologica sia degli avvenimenti che dell'influenza della politica statunitense nel sud-est asiatico, ma una disamina di alcuni tra i più importanti eventi bellici di questo conflitto, che peraltro nel corso dei decenni a venire furono oggetto di approfonditi studi letterari ed in alcuni casi di trasposizioni cinematografiche.
Il relatore nella prima parte del suo intervento accenna alla condotta che gli Stati Uniti tennero almeno fino al 1964, anno nel quale, di fatto, si data l'inizio della guerra vera e propria; il conflitto vietnamita, infatti, si dipana attraverso un trentennio a partire dal 1946, anno nel quale ebbe inizio la lotta di liberazione contro il colonialismo francese e che ebbe il suo esito felice nel 1954, dopo la cruenta battaglia di Dien Bien Phu, che nel maggio di quell'anno condusse il corpo di spedizione francese alla totale sconfitta.
In quegli anni l'amministrazione Usa, che fino al 1952 era gestita dai democratici, salvo poi passare in mano ai repubblicani, tenne un ruolo di basso profilo, limitandosi ad un appoggio logistico.
Dal 1954 in poi, partiti i francesi, Eisenhower, allora al primo mandato presidenziale, non ritenne di doversi impegnare nella regione e per una serie di motivi, che Neil Sheenan nella sua opera "Vietnam una sporca bugia" (edizioni Piemme), libro che ottenne peraltro il Pulitzer, descrive puntualmente.
In primo luogo, non era chiaro se Ho Chi Minh volesse entrare nell’orbita sovietica oppure in quella cinese; in secondo luogo è importante precisare che lo stesso leader vietnamita, almeno agli inizi, sembrò voler seguire una linea fortemente indipendente, sulla falsariga di Tito in Jugoslavia, che era arrivato ad una rottura aperta col mondo sovietico; in terzo luogo Ike riteneva più importante contrastare la crescente potenza cinese.
Dopo la rivoluzione del 1949, infatti, l'ascesa al potere del partito comunista rendeva prioritario occuparsi del gigante asiatico più che di un'area nella quale, almeno per quegli anni, il valore del conflitto era ritenuto di carattere solo regionale.
In quarto ed ultimo luogo nel 1953, dopo tre anni di guerra, gli Usa erano usciti dal conflitto in Corea decisamente provati ed un ulteriore impegno in Asia, a fronte di quello già consistente, sia durante che dopo la guerra in uomini e mezzi sulla linea del 38° parallelo non sarebbe stato accettato né compreso dalla popolazione.
Pertanto, si preferì rimandare il tutto a tempi migliori, limitandosi ad un appoggio tramite consiglieri militari e mezzi, anche se gli eventi che si presentarono scompaginarono i piani dell'amministrazione americana.
Il Vietnam era stato formalmente diviso in due Stati, sebbene nel 1956 avrebbero dovuto tenersi elezioni generali che di fatto ne avrebbero segnato la riunificazione.
Ma il governo del sud, intimorito dal crescente consenso che i comunisti ottenevano sopratutto nelle aree rurali rifiutò la pista elettorale, adducendo vari pretesti, e chiese agli americani un appoggio sempre maggiore.
Sempre riottoso, Ike preferì continuare nella sua condotta.
Stanley Karnow, giornalista esperto in questioni strategico-militari, del resto, rimarca, nella sua opera "Vietnam.
Come e perché gli Usa persero la guerra" (edita da Rizzoli), questo aspetto della politica repubblicana degli anni Cinquanta, ancora poco aperta a questioni internazionali di ampio respiro e diretta solo a contrastare la potenza sino-sovietica rispettivamente in aree come quella europea e del mar del Giappone.
Dopo un periodo di sostanziali scaramucce ed episodi militari circoscritti, all’inizio degli anni Sessanta sembrò arrivare il periodo della grande svolta, agevolata dalla contemporanea ascesa al potere di Kennedy negli Usa e di Diem alla presidenza del Vietnam del Sud.
Il primo, a differenza del suo predecessore, sentì più forte l'esigenza di intervenire nell'area asiatica, sebbene in modo non ancora diretto.
Kennedy, infatti, avendo prestato servizio durante il secondo conflitto mondiale nel Pacifico, e, sempre a quanto riferisce Sheenan, essendo profondo conoscitore delle questioni asiatiche, ritenne un errore aver sottovalutato le conseguenze che in paesi come Indonesia, Malesia, Thailandia, Filippine, Australia e Nuova Zelanda, avrebbe potuto avere una crescente influenza comunista nella regione.
Ad ogni modo egli preferì evitare ugualmente, almeno all'inizio, un coinvolgimento profondo, optando invece per un appoggio sempre crescente in termini di consiglieri militari, reparti ed unità speciali (più di 16.000 unità per tutto il 1962) e mezzi, facendo in modo che il Vietnam del Sud potesse addestrare ed utilizzare un esercito -allora denominato ARVN- efficiente ed in grado di contrastare le forze partigiane del sud e quelle regolari del nord qualora se ne fosse presentata la necessità.
Diem, asceso al potere nel 1961, si rifiutò ancor più dei suoi predecessori di indire elezioni generali.
Chiuso nel suo odio anticomunista, anzi scatenò una repressione ancora più dura nei confronti di quelle aree del paese ritenute di appoggio alla guerriglia partigiana, facendo in modo che i suoi accoliti compissero atrocità nei confronti della popolazione delle campagne e disattendendo qualsiasi tipo di riforma o di politica che potesse accattivargli le simpatie delle popolazioni rurali, contravvenendo in questo atteggiamento ai consigli che gli venivano rivolti dai rappresentanti del governo Usa visto che un atteggiamento benevolo nei confronti delle popolazioni rurali aveva sortito effetti positivi nell’esperienza filippina, durante il secondo conflitto mondiale, nel contesto dell’offensiva contro i giapponesi.
Il sentire da parte del popolo la presenza americana come una seconda invasione dopo quella francese, unita alla politica repressiva del governo del sud, rafforzò la posizione delle forze comuniste, le quali, del resto, usarono la brillante tattica di presentazione della loro lotta nei confronti di popolazioni spesso culturalmente arretrate non fondata sulla contrapposizione ideologica, ma come una lotta di liberazione nazionale.
Sheenan rimarca come esse d'altronde mantennero sempre il nome di Vietminh, che ne esaltava lo spirito nazionalista e di riscossa patriottica, in contrapposizione al nome coniato dagli americani di Vietcong, volto ad evidenziarne, in senso spregiativo, il solo aspetto comunista.
Si arriva così al 1964, anno della svolta.
Al potere negli Usa c'è Johnson, democratico del Texas, succeduto a Kennedy dopo l'attentato di Dallas.
Più ancora del suo predecessore, Johnson ritenne fondamentale un impegno in Vietnam, anche attraverso l'impiego di truppe su vasta scala.
Egli d'altronde sperava di ripetere, o addirittura migliorare, il risultato della Corea, nella quale il vasto impiego di contingenti militari prima ed il mantenimento di una consistente presenza dopo, aveva indotto le forze comuniste a più miti consigli.
Nel 1963, inoltre, nel Sud era salito al potere, con un colpo di Stato, il generale Thieu che, superando di gran misura Diem, scelse di attuare la strategia della repressione affiancata da una sempre più incalzante richiesta di aiuto agli americani.
Nell'amministrazione americana, d'altronde, oltre che negli alti comandi delle forze armate, a dominare non erano tanto le colombe quanto i falchi: basti citare Robert Mc Namara, segretario alla difesa; McGeorge Bundy, consigliere per la sicurezza nazionale; Dean Rusk, Segretario di stato.
Addirittura il generale Westmoreland, secondo quanto Sheenan riporta, affermò durante un briefing con i suoi ufficiali: “Amici miei, so che non è il massimo, ma è l'unica guerra che abbiamo. Sappiatevela godere”.
Sentore di ciò che albergava nella mente degli altri vertici Usa, che vedevano in un massiccio dispiegamento di forze l'unica vera condotta di guerra e che prevedevano una rapida vittoria, sottovalutando in maniera molto pericolosa l'avversario che avrebbero avuto di fronte.
Nell'aprile 1964 la torpediniera americana Maddox fu attaccata da unità nordvietnamite nel golfo del Tonchino.
Fu questo il pretesto che scatenò il coinvolgimento diretto degli Usa, che a partire dal marzo 1965 schierarono un numero sempre crescente di unità.
Lo sbarco di due battaglioni di marines a Da Nang (ampiamente ripreso e documentato dalle televisioni e dalla stampa) il 7 marzo di quell'anno fu solo il simbolo di come la politica americana nei confronti dell'Indocina stesse attraversando una preoccupante escalation interventista.
Nel novembre di quello stesso anno vi fu il primo grande scontro tra forze Usa ed esercito regolare nord vietnamita.
La prima divisione di cavalleria elitrasportata fu duramente impegnata dal 10 al 14 novembre; uno spaccato di quei giorni è documentato dal giornalista Joseph Campbell nel suo libro "Eravamo soldati… e giovani", da cui nel 2002 fu tratto un film, diretto da Mel Gibson, "Fino all’ultimo uomo".
Per la prima volta, le forze americane rischiarono di essere travolte; il 7mo cavalleria, al comando
del Colonnello Moore, fu costretto a richiedere il protocollo Broken Arrow, ovvero l’invio immediato di ogni mezzo aereo e di tutto l'appoggio di fuoco possibile ad un'unità sul punto di essere spazzata via.
Ciò permise agli americani di riorganizzarsi e la mattina del 14, con abile manovra aggirante, di sorprendere alle spalle le unità dell'esercito del nord e costringerle ad una rapida ritirata.
Sul campo, è vero, gli usa avevano vinto, ma la perdita di almeno un quarto delle forze impegnate aveva fatto capire che la guerra non sarebbe stata né rapida né facile.
Nonostante ciò, Johnson si intestardì nel suo desiderio di vincere i comunisti con la forza, tanto è vero che per tutto il 1967 le forze Usa di ogni arma e specialità raggiunsero oltre il mezzo milione di uomini; nel 1966, inoltre, la Corea del sud aveva inviato in Vietnam un proprio contingente, che al massimo della portata raggiunse i 50.000 uomini.
A partire dalla fine dello stesso 1966 per effetto dell'accordo Anzus stipulato a Melbourne, a Australia e Nuova Zelanda inviarono alcuni battaglioni.
É del 1967 il primo scontro in cui è documentato un massiccio impiego di mezzi (caccia e bombardieri, elicotteri, artiglieria pesante) da parte degli americani.
Mi riferisco alla battaglia di Dak To, del novembre di quell'anno, nella quale le forze del nord furono contrapposte alla prima divisione di cavalleria aerotrasportata già citata, ed alla 173ma divisione, uno dei migliori reparti dell'esercito americano.
Comandante delle forze Usa era il generale Johnson, il quale attuò una tattica volta non alla conquista delle aree territoriali, bensì all'annientamento totale delle forze nemiche attirandole in una sacca e poi colpendole con un massiccio impiego di ogni arma disponibile.
Di converso, le forze del nord scelsero di adottare la medesima tattica, sebbene la classica dottrina di guerra comunista prevedesse dapprima la conquista delle aree occupate dal nemico.
La battaglia ebbe inizio il 6 novembre per concludersi con la sconfitta delle forze del nord 15 giorni dopo; ancora una volta gli Usa non compresero quale prezzo sarebbero stati costretti a pagare in termini di mezzi e di vite ogni volta che avessero affrontato apertamente le forze dell'esercito del nord.
Ben equipaggiate con le mitragliatrici antiaeree pesanti da 50mm fornite dai sovietici, esse ostacolarono fortemente la precisione dei velivoli americani nel bombardamento.
Vista inoltre l'abilità del manovrare e nel dileguarsi delle truppe Vietminh, la tattica del “colpo di falcetto”, come solitamente veniva denominato quanto appena descritto, fu assai difficile da attuarsi nella sua pienezza da parte dei comandi Usa, che indubbiamente a Dak To conseguirono quella che si suole chiamare vittoria di Pirro.
La strategia del massiccio impiego di forze venne mantenuta almeno fino all'inizio del 1968, unita ad una massiccia campagna di bombardamenti su Hanoi ed i principali centri militari e produttivi del nord.
Alcuni settori del governo e delle forze armate spingevano affinché si invadesse via terra e mare il nord, ma al sopraggiungere del Tet, il capodanno vietnamita, forze regolari nord vietnamite e Vietminh del sud sferrarono un offensiva così massiccia da penetrare fin dentro i palazzi del potere di Saigon.
É il 27 gennaio 1968, 40 città vengono attaccate e Hue, l'antica capitale dell'impero Viet,viene occupata dalle truppe partigiane.
Senza dubbio la battaglia per la riconquista di Hue fu una delle più cruente di tutta la guerra.
Stime ufficiali dell'epoca riferirono di circa 1.800 tra morti e feriti per le truppe americane e sudvietnamite e più di 3.000 tra le forze comuniste, senza contare le perdite civili.
Hue, ormai comunque ridotta ad un cumulo di gelide macerie, venne riconquistata solo il 24 febbraio dai reparti della 101 aerotrasportata.
L'offensiva del Tet dimostrò comunque che le forze guidate dal generale Nguyen Van Giap potevano ancora colpire duramente e che la strategia di Johnson era destinata al fallimento.
Illustri esponenti del governo Usa,come McNamara, in aperto dissenso con la politica del presidente, lasciarono il governo già alla fine del 1967; al tempo stesso, il diffondersi di movimenti d’opinione in aperta opposizione al conflitto, viste anche le atrocità commesse nei confronti delle popolazioni civili dalle truppe americane e sudvietnamite, documentate e rese note al grande pubblico dai reporter dell'epoca, portò Johnson a non ricandidarsi alla presidenza alla convention democratica dell'agosto di quell'anno.
Su questo argomento credo sia opportuno riprendere una riflessione di Mitch Weiss, in un volume uscito nel 2005, "Sette pezzi d'America", che ripropone alcuni grandi reportage-Pulitzer, dalWatergate ai preti pedofili, dallo scandalo delle multinazionali del tabacco al Vietnam.
La condotta del primo periodo di guerra, ma non solo, fu spesso caratterizzata da veri e propri crimini rimasti impuniti per lungo tempo, un po' per calcolo politico, un pò per varie altre ragioni.
«Pezzi» che raccontano un giornalismo che ha ben chiaro il suo ruolo di controllo del potere e che, caso sempre più raro, riesce ad incidere sulla realtà.
Giornalismo americano, un tempo il più libero e potente del mondo, oggi sotto accusa per alcune sospette compromissioni con il potere.
Una debolezza che non fa parte della sua storia.
Mitch Weiss, con il collega Michael D. Sallah, lavorò per mesi su alcuni documenti decisamente sconvolgenti.
Riportavano fatti relativi ad un'unità speciale dell'Esercito, i "Tiger Force", che operava nel 1967 a Quang Ngai (poche miglia da My Lay).
E soprattutto svelano le metamorfosi che la guerra può provocare in individui apparentemente normali.
«Vivevamo alla giornata» raccontò al Toledo Blade l'ex sergente William Doyle «non ci aspettavamo di uscirne vivi. Quindi facevamo quel cazzo che volevamo, soprattutto se serviva a restare vivi. Per vivere bisognava uccidere».
I soldati descrivono atroci esecuzioni di prigionieri: militari e civili, vecchi e donne, bambini.
Ci furono militari che testimoniarono come un soldato della Tiger Force «dopo aver tagliato la gola a un prigioniero gli ha preso lo scalpo e l'ha messo sulla punta del fucile».
Nella provincia di Quang Ngai, terra sacra e ancestrale per i vietnamiti, l'unità americana sembrava vagare in cerca di sangue.
Bastava rifiutarsi di abbandonare i villaggi per essere uccisi. «In giugno sparano a un uomo anziano, vestito di nero, che credevano fosse un monaco buddista, perché ha protestato per il trattamento riservato ai contadini».
Sempre a giugno, un ragazzo di 15 anni venne trucidato dal soldato Sam Ybarra per prendergli un paio di scarpe da ginnastica.
Inutilmente: le scarpe, ad Ybarra, non entravano. Al cadavere del ragazzo venne comunque inflitto il trattamento «rituale» dei Tiger Force: «Il soldato gli tagliò le orecchie e le infilò in uno dei sacchetti delle razioni».
I soldati, con le orecchie dei morti, facevano collane che portavano infilate nei lacci degli anfibi. Confessa l'ex medico del plotone: «Ci fu un periodo in cui quasi tutti ne avevano una al collo».
Per sgombrare i villaggi i soldati li incendiavano.
Per convincere la gente a fuggire la Tiger Force uccise abitanti a caso.
Un episodio può essere esemplificativo. Bevono molta birra e quando incontrano il signor Dao sono già ubriachi.
Lo afferrano per la barba grigia e lui giunge le mani, in preghiera. Viene colpito con la canna di un M-16, poi «mentre il medico cerca di curarlo, il tenente Hawkins gli spara in faccia con un Carabine-15».
Interrogato, il tenente spiegò: «Gridava così forte da attirare l'attenzione del nemico, volevo eliminare subito il problema».
Il soldato semplice Ken Kerney riferì ciò che gli era stato detto dai comandanti: «Quello che succede qui, qui deve restare. Non raccontare a nessuno le cose che vedi. Se scopriamo che hai parlato, quello che ti faremo non ti piacerà».
A settembre arrivò un nuovo comandante, Gerald Morse, che cambiò nome alle tre compagnie. Invece che A,B,C, le ribattezzò Assassins, Barbarians, Cutthroats (tagliagola). Lui diverrà una legenda, il Ghost Rider, il Cavaliere fantasma.
Dopo la morte di alcuni dell'unità, il Cavaliere fantasma cominciò ad attaccare i villaggi per vendetta.
«Non avevo mai visto niente del genere» ricorda il medico dei Tiger Force. «Arrivavamo e facevamo piazza pulita della popolazione».
Ricorda il sergente William Doyle: «Se entravo in un villaggio e non erano tutti stesi per terra, io sparavo a quelli ancora in piedi».
Una ragazzina di 13 anni venne violentata e sgozzata. «Un soldato decapitò un neonato per prendergli una collana».
Un uomo anziano venne ucciso per provare una nuova calibro 38.
Il battaglione era il 327°, e fu chiesto loro di fare 327 vittime. Un gioco. I soldati dicono che l'ordine è arrivato dal Cavaliere fantasma. Un ufficiale si giustifica: «Laggiù nella giungla non c'erano poliziotti né giudici, non c'era legge né ordine».
Sam Ybarra, l'uomo che aveva ucciso per le scarpe, di ritorno in patria era diventato instabile.
La madre ricorda che piangeva sempre.
Era stato interrogato sui crimini della Tiger Force e congedato con disonore.
Disse: «Ho chiesto a Dio di perdonarmi per quello che ho fatto».
Morì a 36 anni.
Furono diversi i militari indagati, ma tutto restò “in famiglia”. Scrisse il Blade: «Nel 1967 i comandanti sapevano, ma rifiutarono di aprire un'indagine».
Lo dimostra: c'erano denunce che non avevano avuto seguito, si finse di indagare incoraggiando gli interrogati a tacere per non essere processati.
Nel '75 sei imputati furono congedati evitando così il processo.
Nel '73 rapporti sui Tiger Force arrivarono alla Casa Bianca (presidente Richard Nixon).
I grandi giornali americani, dopo l'inchiesta del Blade, ignorano la notizia o la relegano in poche righe.
Solo Seymour Hersh, sul New Yorker, lamentò come «un'indagine tanto straordinaria ha potuto rimanere invisibile».
Alle elezioni del 1968 trionfò il repubblicano Nixon, il quale promise un progressivo disimpegno americano dal conflitto, anche se egli non nascose ancora la volontà di proseguire nel conflitto stesso, sebbene con una strategia rimodulata, fondata su colpi più mirati da assestare alle forze comuniste, fino ad arrivare all'uso di armi nucleari tattiche ove se ne fosse rilevata la necessità.
Nixon auspicava comunque una progressiva “vietnamizzazione” del conflitto, riducendo le forze terrestri americane e mantenendo solo quelle aeree e navali in numero consistente, ed addestrando ed incrementando l'esercito del sud in maniera più efficiente e moderna.
Crebbero intanto nel paese i movimenti di opposizione che arrivarono anche nel cuore delle città americane, e si diffusero al resto del mondo.
Nonostante tutto, ancora, il governo Usa cercava di convincere l'opinione pubblica interna ed occidentale in genere della bontà e necessità dell'intervento in Vietnam (vennero anche girate alcune pellicole di intento celebrativo e propagandistico come "Berretti verdi" del 1969, con John Wayne).
Una delle più sanguinose battaglie di quegli anni fu quella che si ebbe tra reparti della 82ma divisione aerotrasportata e dell'esercito del nord per la conquista di quota 937 nella valle di Ashau.
Tra il 10 ed il 20 maggio del 1969 le perdite da ambo le parti furono pari al 70% delle forze totali; gli americani provarono per almeno 10 volte ad arrivare in cima alla collina, ma i bunker delle truppe Vietminh, ben dissimulati nel terreno, richiedevano un numero di offensive consistente al fine di poterli snidare e distruggere; alla fine della battaglia quel luogo assunse il nome di "Hamburger Hill" (John Irvin immortalò questo episodio nell'omonimo film del 1987, forse uno dei più commossi omaggi ad una generazione distrutta).
Peraltro, tre giorni dopo la conquista dell'obiettivo, gli americani vennero nuovamente ricacciati indietro dalle truppe Viet.
Nel lasso di tempo che seguì entrambe le parti comunque non avanzarono sostanzialmente dalle loro posizioni e alla fine del 1969 si avviarono a Parigi colloqui diplomatici per arrivare ad una soluzione del conflitto; il governo americano inoltre programmò una progressiva e consistente riduzione del proprio contingente-ormai pari ad un terzo di tutte le forze armate americane, nonostante gli alti vertici militari chiedessero a Nixon ancora più truppe; ma il presidente oppose un netto rifiuto.
Nel 1970, si tentò di cambiare parzialmente strategia, tagliando le linee di rifornimento alle truppe Viet; Cambogia prima e Laos dopo vennero invasi da truppe sudvietnamite con appoggio di aerei ed elicotteri statunitensi, senza che comunque se ne traesse alcun risultato concreto.
Ormai Nixon era invischiato in un pantano dal quale non riusciva ad uscire: da un lato il sempre crescente dissenso nei confronti della sua politica, dall'altro i settori più oltranzisti del governo e delle forze armate, oltre che del paese, che non volevano piegarsi al comunismo.
Nel frattempo, i paesi alleati agli usa che avevano inviato propri contingenti ritirarono progressivamente le proprie truppe; la Corea completò il ritiro nel 1970, Australia e Nuova Zelanda l'anno seguente.
Nixon d'altronde dimostrò di volersi progressivamente sganciare dal sud est asiatico con il riavvicinamento che tra il 1971 ed il 1972 ebbe con Urss e Cina, paesi anch'essi, sebbene indirettamente, coinvolti nel conflitto (quella che venne chiamata “diplomazia del ping pong”); basti pensare ai primi accordi Salt per la riduzione delle armi strategiche firmati il 22 maggio 1972 coi sovietici ed all'incontro tra Nixon e Mao Tse Tung avvenuto a Pechino-fu la prima visita di un presidente Usa in Cina-nel febbraio dello stesso anno.
Anche se la ripresa dei bombardamenti nello stesso 1972 su Hanoi non sembrò effettivamente far pensare ad una strategia di uscita dal conflitto vietnamita, la conquista da parte delle forze comuniste della provincia di Quang Tri nel marzo di quell'anno bloccò ogni velleità di avanzata verso nord da parte degli Usa, che nel marzo dell'anno successivo, a Parigi, firmarono un accordo di pace; dell'oltre mezzo milione di soldati presente nel 1967, solo 6.800 uomini rimasero a quella data in Vietnam.
Era la prima grande sconfitta che gli Usa avessero mai subito: l'uso di armi sofisticate, dei defolianti, del terribile agente orange, non era riuscito a piegare le forze comuniste, che avevano seguito fino in fondo l'assunto di Ho Chi Minh anche dopo la sua morte (avvenuta nel 1969):“potete uccidere milioni di noi, ma alla fine saremo noi a vincere”; Saigon venne conquistata dalle truppe del nord e dai Vietminh il 30 aprile del 1975, che travolsero senza eccessiva fatica le forze del governo fantoccio del presidente Dimh instauratosi da soli 3 giorni.
Senza dubbio una delle guerre più lunghe del 20mo secolo, quella del Vietnam fu una vera macchia indelebile per il popolo americano: 58.270 caduti accertati, circa 2000 dispersi (che per lungo tempo, anche con intenti propagandistici, si ritenne fossero detenuti in campi di prigionia o addirittura che fossero stati inviati in Unione Sovietica, anche se già dalla fine degli anni ottanta molti di loro furono catalogati come KIA, acronimo di Killed in Action, ucciso in azione), oltre 100000 mutilati od invalidi, una tremenda crisi economica e sociale furono il terribile prezzo che gli Usa dovettero pagare per aver sottovalutato i loro avversari.
Del resto, leggendo le opere sia di Sheenan che di Karnow, gli autori che qui più volte ho voluto citare, si può senz'altro affermare che essi fotografarono in maniera esatta i sentimenti di quei tempi di una nazione in forte conflitto con se stessa.
Essa non avrebbe voluto abbandonare i suoi ragazzi “in qualche lurida palude”, un gergo molto usato in quei tempi; ma per gli americani non fu possibile sopportare che i loro figli si macchiassero di atrocità contro le popolazioni inermi e combattessero in una Dirty war (sporca guerra), nella quale l'America mandò a morire i suoi soldati contro un popolo che, più che per un'ideologia, lottava per la sua dignità e libertà, sebbene poi il Vietnam riunificato fosse entrato nella sfera di influenza sovietica.
Gianluca Tripodi conclude la sua interessante disamina citando testualmente quanto ebbe a dichiarare a tal proposito il maggiore Michael Davis O'Donnel, il primo gennaio del 1970 in quel di Dak To: «Se ne siete capaci, conservate per loro un posto nella vostra memoria, mentre andate verso luoghi dove loro non potranno più andare. Non abbiate vergogna di ammettere che li avete amati, anche se non è stato del tutto vero. Prendete ciò che vi hanno lasciato e vi hanno insegnato con la loro morte, e conservatelo insieme alla vostra. E quando verrà il momento in cui gli uomini decideranno di poter chiamare la guerra un'insana follia, sostate un momento ad abbracciare quegli eroi gentili che avete lasciato indietro».


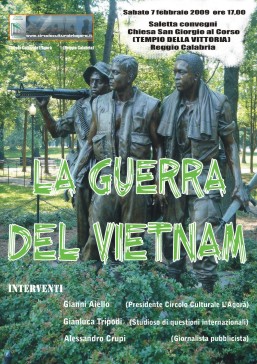
E. J. HAMMER, "The Struggle for Indocina: 1940-1955", Stanford University Press,1966;
J. CHESNEAUX, "Perché il Vietnam resiste. Le radici storiche e ideologiche di una guerra rivoluzionaria", Einaudi, 1968;
N. CHOMSKY, "La guerra americana in Asia. Saggi sull'imperialismo", Einaudi, 1969;
M. GALLUPPI, Il Vietnam dalla dominazione francese all'intervento americano, Laterza,1972;
F. FITZGERALD, Il lago in fiamme: storia della guerra del Vietnam,Einaudi, 1974;
F. MAZZEI, "il conflitto vietnamita: storia, ìtattica e strategia delle operazioni aeree", Ìsaam, 1980;
H.G. SUMMER, "On Strategy: A Critical Analysis Ot The Vietnam War", Novato, 1982;
S. KARNOW, "Storia della guerra del Vietnam", Rizzoli,1989;
C. T. KAMPS jr. "storia della guerra del Vietnam", Gremese,1990;
G. MAMMARELLA, "Da Yalta alla perestrojka", Laterza, 1990;
S. KARNOW, "Storia della guerra del Vietnam", Rizzoli, 1992;
G. MAMMARELLA, "L’America da Roosevelt a Regan: Storia degli Stati Uniti dal 1945 a oggi", Laterza, 1992;
G. C. HERRING, America’s Longest War: The United States and Vietnam,1950-1975, McGraw-Hill, 1996;
H. KISSINGER, "L’Arte della Diplomazia", Sperling & Kupfer, 1996;
J. DUROSELLE, "Storia diplomatica dal 1919 ai nostri giorni", F. Angeli, 1998;
G. GIORDANO, " La politica estera degli Stati Uniti: da Truman a Bush 1945-1992", F. Angeli, 1999;
F. MONTESSORO, "Vietnam, un secolo di storia", F. Angeli,2000.
